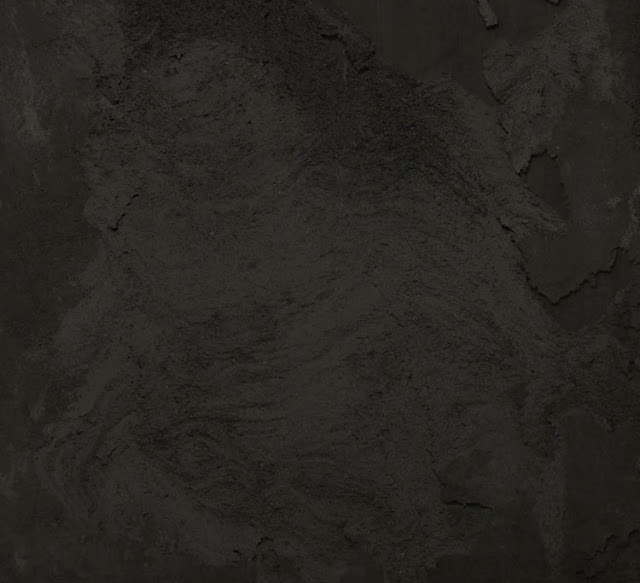… Sussurro. Mi presento con le mie strutture, i marrani, le stelle, le canoe, i sibili, i desideri incolmabili, le esagerazioni … Mi presento con le necessità di tentare le voragini rovesciate che anelano il grande, rosso, grande lampo dell’arte. Arte prima pulsione, Arte veicolo del sogno intelligente, Arte assidua nell’intelligenza. Arte convinta rivoluzione rincorsa, Arte felicità pensante che sogna, che precede l’utopia; Arte elegante, Arte orgogliosa, Arte operaia, Arte sconfitta che sconfigge il buio. Benvenuti.
(Gilberto Zorio, Torino, ottobre 2000)
Questo scriveva l’artista in occasione di una mostra personale nella
città che tanto gli ha dato e alla quale ha dato tanto negli anni
Sessanta, così lontani, così vicini, la bella e algida Torino, quando il
movimento italiano dell’arte povera capitanato da Germano Celant
prendeva sopravvento nel panorama artistico internazionale. Ho riportato
questo pezzo per sottolineare quanto l’artista sia uno di quegli
artisti dotati di una penna straordinaria in grado di investire la
scrittura di potente evocazione e bellezza.
L’arte di Zorio è fatta di oscillazioni temporali, e colmo di
meravigliosa energia torna per quest’anno, nel cuore di Bologna, alla
galleria de’ Foscherari, la stessa che proprio nel 1968, a cura del già
citato Celant ha ospitato la mostra Arte Povera. Le opere oscillano e fluidificano da un secolo al successivo...
vuol essere un viaggio nella poetica dell’artista e nell’arte stessa,
una mostra che raccoglie opere che slittano nelle intensità di mezzo
secolo. Una felice spossatezza, una nostalgia del futuro, come scrive lo
stesso artista. Un’esposizione magica, da fruire anche al buio, per
assorbire tutta l’incandescenza e la forza della visione immaginifica di
Zorio. Una visione eccitata, costruita da simboli e archetipi, ma che
ben si tengono lontani dalle metafore, all’artista infatti ha da sempre
interessato la potenza stessa dell’immagine o del materiale impiegato, e
non il loro valore simbolico.
Marrani volteggianti, motori, sibili, canoe, sospensioni, pelli di
animali, stelle, letti, ampolle in pyrex, metalli, liquidi, giavellotti,
è impossibile non rimanere sorpresi e incuriositi da questi strumenti,
mistici, ambigui, ancestrali, dall’esistenza possibile e impossibile.
Quella di Zorio è una continua ascensione alla speranza, l’arte acquista
significato solo come atto di estrema e disperata speranza, una
possibilità di redenzione, miglioramento, innalzamento, purificazione.
Contrasti, appoggi, le dicotomie si innalzano, in modo che la galleria
acquisti una dimensione eterea, preziosa, ritagliata fuori da un tempo
prestabilito, il tempo diventa per un momento democratico, circolare,
forse ellittico, il tempo scivola, fluttua, viaggia, come glassa, come
burro caldo sul pane croccante, si infrange, si scioglie e si muove tra e
con i nostri sensi.
È un mostra che slitta tra il silenzio e il rumore, tra la luce e il
buio, tra la pesantezza del metallo e la fluidità e mobilità di un
liquido, tra la concretezza di una forma o di un oggetto e l’aleatorietà
di un pensiero, qualunque esso sia. Con la fruizione al buio, ci
troviamo di fronte a un altro volto, a un’altra mostra, a un altro
ambiente, siamo immersi in un percepire stellare, cosmico, la materia
pulviscolare si dipana nello spazio, senza peso, illuminando le nostre
attese. Fremiti di galassia, un concretismo magico, straniante, che
trova una vibrazione materica nelle pulsazioni luminose.
Letto del 1966 e Per purificare le parole del 1980 sono due opere storiche che si fondono temporalmente con le altre presenti del 2016: Marrano con treccia, Canoa aggettante, Stella calibrata.
Che dire su quest’ultima? La stella atavica e cosmica da sempre è
utilizzata dall’artista fin dagli esordi, un simbolo dalla semplice
complessità, antico come le stesse origini dell’uomo, perfetta negli
equilibri e nelle proporzioni, tanto da raccogliere in se stessa le
purità canoniche dell’uomo vitruviano, così elegante da non potere fare
male. La stella catalizza in sé l’energia millenaria del tempo e della
memoria, come elemento costitutivo del DNA del sogno dell’uomo,
appartiene all’altrove e sorregge, o viene sorretta dalle alchimie. Ogni
essere umano è un recipiente di minerali e di acqua, le sue vene, i
polmoni e organi sono uno straordinario laboratorio chimico fatto di
tubi e alambicchi. Così affermò l’artista in una conversazione con Celant.
Tutto in Zorio è trasformazione, come nei processi alchemici
costituiti proprio dagli alambicchi in vetro o in piombo, le
conflittualità di energia scaturite dalla tensione tra i materiali, sono
questi gli ingredienti di una visione mitica di un’arte sia operaia che
sognante. Mettere a nudo i propri strumenti e meccanismi, un'arte
pronta a rivelarsi pur mantenendo un’aura di fascino e mistero, che cede
al dubbio e alla perplessità la sua più segreta energia. L’arte di
Zorio è un’arte alla continua ricerca di un moto di energia pura, di
movimento, di luce, di incandescenza, di reazione, di fluorescenza, di
esplosione cosmica indefinita. Scienza e arte si intrecciano come
impronte in un percorso mistico, enigmatico, dai contorni fragili e
intercambiabili, l’unica certezza è il provocare una visione di
inspiegabile stupore nell’osservatore, che rimane rapito dagli
interstizi inarrivabili della cosmogonia artistica di Zorio.
È così che la Canoa aggettante si libra sospesa per un
viaggio fluido, tra le narrazioni di un’energia, come a colpire la
nostra immaginazione, come una freccia, si fa mezzo per un altrove
luminoso, intermittente, tra i sospiri di una speranza, talvolta
chiamata arte.
Non pensare a quanto è rimasto indietro […] se quanto hai già trovato è fatto di materia pura, non potrà marcire. […] Se è stato soltanto un attimo di luce, come l’esplosione di una stella allora non troverai più nulla quando ritornerai... Ma avrai visto un’esplosione di luce. E anche solo per questo ne sarà valsa la pena.(Paulo Coelho, L’Alchimista, 1995).