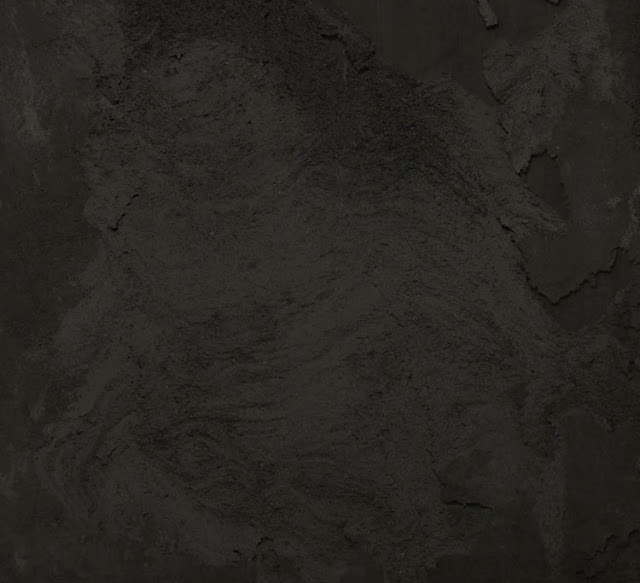Irene Angenica e Davide Da Pieve sono i due giovani fondatori di Porto dell’Arte – Appuntamento per la promozione di artisti in appartamento
nato dalla volontà di promuovere artisti attraverso una serie di eventi
espositivi che si svolgeranno all’interno di un appartamento abitato,
nel cuore di Bologna. Un progetto-scommessa
che vuole essere soprattutto un dialogo-sfida con l’artista messo alla
prova con gli spazi domestici, ma anche una differente modalità di
fruizione per i visitatori.
Porto dell’arte nasce quest’anno
sotto l’insegna della ricerca e della condivisione. Potreste
raccontarci la genesi del progetto, e perché avete deciso di dargli
questo nome?
Cominciamo dal nome, apparentemente banale perché l’appartamento si trova in via del Porto, ma è stato scelto per il suo valore metaforico di luogo di scambio, di crocevia. Il nostro intento è quello di permettere ai giovani artisti di fare esperienza per poter salpare, per rimanere in metafora, verso destinazioni più grandi.
Cominciamo dal nome, apparentemente banale perché l’appartamento si trova in via del Porto, ma è stato scelto per il suo valore metaforico di luogo di scambio, di crocevia. Il nostro intento è quello di permettere ai giovani artisti di fare esperienza per poter salpare, per rimanere in metafora, verso destinazioni più grandi.
Sia tu che Davide avete avuto e
avete importanti collaborazioni ed esperienze formative con istituzioni
artistiche sia all’estero che in Italia. Quando avete deciso di far
nascere questo progetto con la volontà di proporre arte in uno spazio
domestico vi siete ispirati a qualche particolare realtà? Avete qualche
modello di riferimento che sia italiano o straniero?
In realtà la volontà è un po’ quella di rompere con altri luoghi espositivi di questo genere. Noi non siamo né una Home Gallery e tantomeno uno di quei luoghi espositivi casalinghi in cui i proprietari trasformano le stanze in temporanei white cube. Ci siamo documentati sul fenomeno delle mostre in appartamento, ma è difficile ricondurre a una sola esperienza ciò che noi vogliamo fare. Per prima cosa abbiamo delineato delle strade molto precise sia critiche, sia curatoriali; selezioniamo esclusivamente progetti installativi e performativi, perché instaurano un particolare legame con l’ambiente in cui nascono. Gli artisti lavoreranno in un uno spazio fortemente connotato con lo scopo di intrecciare la loro ricerca, il loro stile, con ciò che già si trova nell’appartamento.
In realtà la volontà è un po’ quella di rompere con altri luoghi espositivi di questo genere. Noi non siamo né una Home Gallery e tantomeno uno di quei luoghi espositivi casalinghi in cui i proprietari trasformano le stanze in temporanei white cube. Ci siamo documentati sul fenomeno delle mostre in appartamento, ma è difficile ricondurre a una sola esperienza ciò che noi vogliamo fare. Per prima cosa abbiamo delineato delle strade molto precise sia critiche, sia curatoriali; selezioniamo esclusivamente progetti installativi e performativi, perché instaurano un particolare legame con l’ambiente in cui nascono. Gli artisti lavoreranno in un uno spazio fortemente connotato con lo scopo di intrecciare la loro ricerca, il loro stile, con ciò che già si trova nell’appartamento.
Essere in qualche modo uno
spazio indipendente, dalle scelte di gestione a quelle curatoriali
comporta una grande libertà. Come considerate la pratica curatoriale
delle nuove generazioni? Avete anche in questo caso qualche persona che
stimate? Che ruolo ritenete abbia la curatela oggi? E rispetto alla
critica?
Siamo ben felici di vedere che sta tornando sempre più in voga la pratica di artisti che investono il ruolo di curatore per altri artisti. Questa è una pratica molto vecchia, già nell’Ottocento troviamo i primi “artisti-curatori”, ma resta un fatto molto affascinante e solidale. Noi tentiamo di lasciare un grado di libertà molto alto agli artisti, la nostra è una fucina per giovani, quindi diamo la possibilità di fare un’esperienza espositiva vera e propria: lo scambio di idee, il dialogo sono elementi fondamentali per la creazione e realizzazione dell’opera, ma, una volta effettuata la nostra selezione, cerchiamo di interferire il meno possibile.
Siamo ben felici di vedere che sta tornando sempre più in voga la pratica di artisti che investono il ruolo di curatore per altri artisti. Questa è una pratica molto vecchia, già nell’Ottocento troviamo i primi “artisti-curatori”, ma resta un fatto molto affascinante e solidale. Noi tentiamo di lasciare un grado di libertà molto alto agli artisti, la nostra è una fucina per giovani, quindi diamo la possibilità di fare un’esperienza espositiva vera e propria: lo scambio di idee, il dialogo sono elementi fondamentali per la creazione e realizzazione dell’opera, ma, una volta effettuata la nostra selezione, cerchiamo di interferire il meno possibile.
A proposito di critica, avete
deciso di non accompagnare le esposizioni con alcun testo critico,
nemmeno su sito e sui social dando così importanza alla relazione che si
instaura nell’atto dell’accadimento che avviene nell’incontro tra
artista e spazio, e tra fruitore ed opera. Come mai?
Praticamente ti sei risposta da sola. La nostra volontà è proprio quella di creare un rapporto diretto e in qualche modo speciale tra il visitatore e l’opera esposta. Non c’è dubbio che oggi l’atto critico stia sempre più relegato alla scelta, alla selezione di un’artista, ma la nostra situazione, all’interno di un appartamento, è molto diversa. Quando apri la porta il visitatore diventa un ospite, egli varca la soglia di uno spazio privato che ha delle implicazioni e specificità che altri luoghi non hanno. Dunque accogliere le persone diventa un fatto verbale e la presentazione dell’opera giunge da sé. Nel corso delle nostre mostre non troverete dunque i classici “fogli di sala” ma un invito al dialogo; aspetto che abbiamo cercato di mantenere anche in rete, presentando il lavoro in modo diretto, solo attraverso immagini e video, sfruttando così l’immediatezza e la dinamicità che caratterizza la fruizione dei contenuti presenti online. Stiamo comunque lavorando per la pubblicazione di una raccolta di testi critici che documenterà tutte le prime esperienze di Porto dell’Arte.
Praticamente ti sei risposta da sola. La nostra volontà è proprio quella di creare un rapporto diretto e in qualche modo speciale tra il visitatore e l’opera esposta. Non c’è dubbio che oggi l’atto critico stia sempre più relegato alla scelta, alla selezione di un’artista, ma la nostra situazione, all’interno di un appartamento, è molto diversa. Quando apri la porta il visitatore diventa un ospite, egli varca la soglia di uno spazio privato che ha delle implicazioni e specificità che altri luoghi non hanno. Dunque accogliere le persone diventa un fatto verbale e la presentazione dell’opera giunge da sé. Nel corso delle nostre mostre non troverete dunque i classici “fogli di sala” ma un invito al dialogo; aspetto che abbiamo cercato di mantenere anche in rete, presentando il lavoro in modo diretto, solo attraverso immagini e video, sfruttando così l’immediatezza e la dinamicità che caratterizza la fruizione dei contenuti presenti online. Stiamo comunque lavorando per la pubblicazione di una raccolta di testi critici che documenterà tutte le prime esperienze di Porto dell’Arte.
Paolo Bufalini, il collettivo
CHMOD e Simone Tacconelli sono stati i primi ospiti di Porto dell’arte.
Che rapporto avete instaurato con gli artisti e soprattutto come
definireste il lavoro che hanno deciso di presentare?
Gli artisti sono sempre nostri coetanei questo ci aiuta a creare dei rapporti paritari, si finisce col diventare subito amici. I lavori che ci vengono presentati nascono sempre da un dialogo tra noi, gli artisti e l’ambiente domestico. Paolo, Simone e il collettivo Chmod sono riusciti ad affrontare lo spazio dato modificandolo e interpretandolo secondo il proprio stile e la propria poetica. Nonostante la diversità dei lavori presentati, la necessità di sperimentare è stata continua e costante creando un buon dialogo con l’ambiente circostante.
Gli artisti sono sempre nostri coetanei questo ci aiuta a creare dei rapporti paritari, si finisce col diventare subito amici. I lavori che ci vengono presentati nascono sempre da un dialogo tra noi, gli artisti e l’ambiente domestico. Paolo, Simone e il collettivo Chmod sono riusciti ad affrontare lo spazio dato modificandolo e interpretandolo secondo il proprio stile e la propria poetica. Nonostante la diversità dei lavori presentati, la necessità di sperimentare è stata continua e costante creando un buon dialogo con l’ambiente circostante.
Porto dell’arte nasce in un
preciso contesto culturale. Come vedete inserita, una realtà come la
vostra, all’interno di una città come Bologna, con una precisa storia e
un preciso background culturale? E soprattutto perché proprio Bologna?
Per necessità di studio e lavorative o perché ritenete che sia ancora
una città sulla quale si possa investire e scommettere?
Un po’ entrambe le cose. Studiamo e lavoriamo a Bologna e pensiamo che questa sia una città dove i giovani sono sempre in fermento. Proporre nuove esposizioni significa voler dare una voce in più alla cultura di questa città, creare la possibilità di mettere in pratica un sfida ulteriore, per giunta in uno spazio angusto e più complesso rispetto alla norma.
Porto dell’arte si presenta allo
stato attuale come un interstizio flessibile e prismatico all’interno
del quale tutto (dallo spazio domestico all’opera proposta) interagisce
con l’altro. Che feedback avete ricevuto dai visitatori, dagli artisti e
dagli altri operatori culturali in queste vostre prime esposizioni? E
che obiettivi si pone, porto dell’arte nel futuro prossimo?
Abbiamo ospitato molti visitatori,
alcuni di essi estranei al mondo dell’arte contemporanea e soprattutto
siamo riusciti a coinvolgere molti giovani. Secondo noi questo è un
punto a nostro favore, vuol dire che stiamo facendo un lavoro che
coinvolge la nostra generazione. Allo stesso modo artisti, docenti,
operatori culturali e alcuni galleristi stanno frequentando il nostro
spazio e, anche da parte loro, fin ora abbiamo ricevuto solo feedback
positivi, ma attendiamo ansiosi anche quelli negativi, spesso più
costruttivi e stimolanti! Per quanto riguardo il futuro, abbiamo già una
serie di mostre programmate che sveleremo di volta in volta e speriamo
che l’attenzione resti alta come è successo sin ora.
Ultimissima domanda, siete
entrambi molto giovani e sappiamo bene come sia difficile lavorare
nell’ambito culturale, tant’è che cimentarsi in attività di questo
genere diviene quasi un atto di coraggio. Cosa vi ha portato ad
appassionarvi all’arte?
I: La mia passione per l’arte è stata graduale, non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sicuramente le personalità che hanno influito a fomentare questa mia passione sono state tante, impossibili da citare tutte, ma se c’è un artista a cui potrei accendere un lumino devozionale quello è sicuramente Kurt Schwitters.
D: Ho frequentato una scuola d’arte già dalle superiori, e al contempo ho sempre saputo che non avrei mai fatto l’artista. Penso sia fondamentale non riflettere solo sul pensiero di un critico o di un artista, ma al contrario, è importante cercare sempre nuovi stimoli per migliorarsi e proseguire la propria strada.
Federica Fiumelli